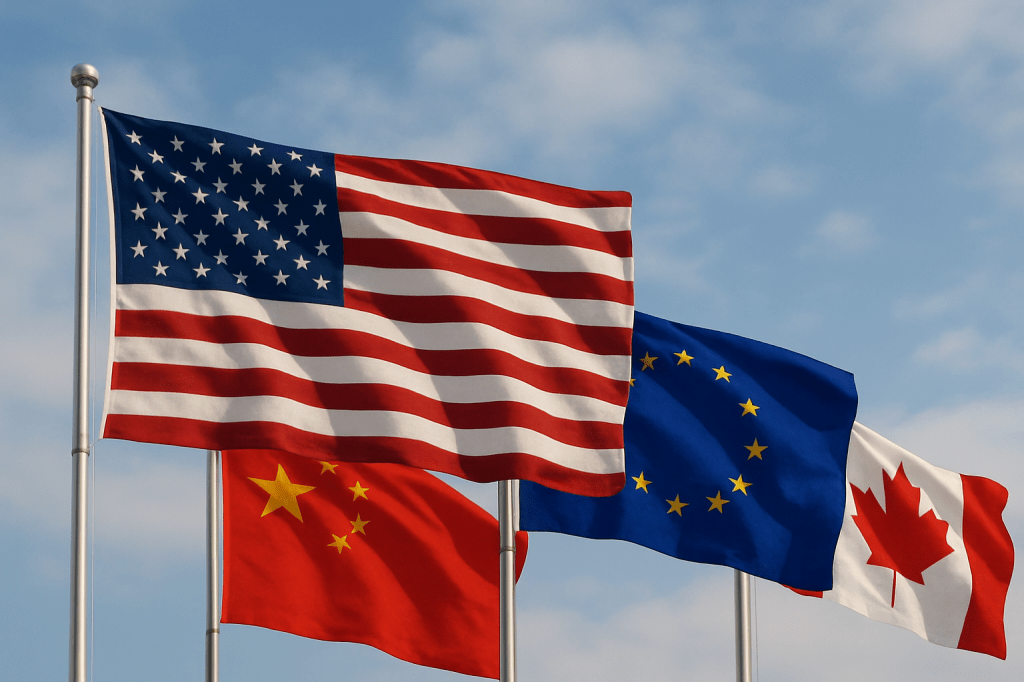
Con il secondo mandato di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti, ritorna sulla scena della prima superpotenza mondiale la politica di isolazionismo e regionalismo che, a più riprese nella storia a stelle e strisce, è avvenuta quando il Paese si sentiva minacciato o aveva bisogno di riprendere slancio interno. Si ricordino, ad esempio, la dottrina Monroe di inizio ‘800 con un focus strategico ed esclusivo sul continente americano (incluso, a seguire, il Sud America), l’isolazionismo prima della Prima Guerra Mondiale e l’isolazionismo tra le due guerre mondiali. Questo approccio fa da controbilanciamento a un secondo approccio del Paese che è la spinta internazionalista (più marcata dal secondo dopoguerra con il progetto delle Nazioni Unite), per diventare non solo spettatore del Mondo e delle sue interazioni, ma un attore protagonista, “esportatore netto” dei valori come la democrazia, la globalizzazione, la finanziarizzazione delle economie (in primis con lo strumento del dollaro come valuta globale di scambio). Con la spinta regionalista-isolazionista, il Presidente-tycoon, eletto per la seconda volta, non rinuncia a un ruolo di superpotenza per gli Stati Uniti, ma vira su scopi che non pongano il Paese come attore universale, ma solo “particolare”, soprattutto per quanto concerne interessi primari e ben chiari. L’aggressività (in etimo latino di “andare -in-contro”) è quindi verso le problematiche di quelli che sono ideali o reali attraversamenti di confini, siano quelli fisici scavalcati dall’immigrazione clandestina, sia quelli “ideali” che formano gli accordi commerciali in cui gli USA sarebbero stati sfruttati in modo sbilanciato dai partner. Il consolidamento regionale passa attraverso anche le pretese territoriali dell’area geografica vicino al Paese; dunque le richieste di Territori da Canada, Groenlandia, Panama… per creare una “fortezza” regionale che possa assicurare un dominio mondiale non scalfibile e che non richieda interventi in tutto il globo (soprattutto militari) per affermare la potenza. I punti su cui Trump articola questa strategia sono dunque i dazi (una guerra commerciale verso amici e nemici), il ritiro parziale degli Stati Uniti dalle Organizzazioni Internazionali (ONU, OMS, USAIDS ), ma anche una riconfigurazione degli accordi militari (NATO), intesi più come accordi bilaterali che come contesto generale di difesa di comuni interessi (valori?!).
Il terreno su cui Trump costruisce questo nuovo approccio è, d’altra parte, parecchio solido e giustificato… dopo decenni di interventi militari degli Stati Uniti, quasi tutti fallimentari, in mezzo pianeta, a partire dalla guerra del Vietnam (1965) fino al recente supporto all’Ucraina, passando per l’Afghanistan (2001), la Siria (2011), la Libia (2011), l’Iraq (2003). Tutte azioni che sono già state valutate fallimentari dalla Storia, iniziative costose in termini di vite e di risorse economiche (qualche trilione di dollari) e controproducenti…come nel caso del terrorismo internazionale, esito dei vuoti della democrazia imposta e fallita.
Sullo sfondo della nuova politica a stelle e strisce c’è una maggiore focalizzazione strategica su ciò che potrebbe minacciare, realmente o in modo presunto, la supremazia e la sicurezza degli USA: la più ampia ascesa tecnico-economico-militare della Cina e, come primo dossier caldo a riguardo, la disputa geografica di un territorio – quello di Taiwan – preteso dalla Cina. Una miccia difficilmente non infiammabile e che richiederebbe agli USA una presa di posizione militare e politica, a difesa dell’isola, inevitabile… un gioco allo scoperto sul ruolo di superpotenza mondiale.
Paradossalmente, la politica economico-commerciale di Trump, così impostata, sembra minacciare, invece, quelli che sono stati gli asset riconosciuti globalmente della politica USA all’estero, e cioè la cultura popolare e valoriale, la dollarizzazione, il ruolo di “poliziotto del mondo” e quindi la deterrenza internazionale, la supremazia tecnologica e accademica, la competenza di creare big tech companies oligopoliste (Silicon Valley).
Se sembra dunque che un regionalismo sia la contromisura più adeguata, dopo decenni di interventi militari errati in diversi scenari, pare anche che i temi scelti per un nuovo rinforzo interno potessero essere scelti partendo da quei temi per cui gli USA fossero già riconosciuti e rispettati globalmente (Soft Power) e non indebolendo, con una guerra commerciale, la rete di partnership strategiche commerciali e militari già consolidata dall’Impero, soprattutto nella sua primaria area geografica di interesse (Europa) ! Inoltre non è possibile prevedere compiutamente quali siano le conseguenze economiche domestiche di queste misure: inflazione, meno domanda interna, de-industrializzazione per componenti non più importate, fuga di capitali e di talentie etc.
Il Presidente Trump, più che da un calcolo ponderato circa i rischi a lungo periodo, sembra essere stato guidato – in queste scelte – dagli eventi connessi a una tendenza storica isolazionista che si ripete – quasi da sé – dopo un periodo di interventismo eccessivo, condizionato dalle promesse elettorali che vuole rispettare. Soprattutto da una certa immagine che al Tycoon piace mantenere.: di hard dealer… di uno che la spara alta per ottenere quello che vuole, perché al tavolo delle trattative ci sa fare. Un bias professionale, comportamentale che non è sfuggito alle sue controparti, amiche o rivali che siano e che hanno imparato a resistere alla prima “sparata” per ricavare, a seguire, margini di negoziazione più rilevanti. E se è vero che in UE, alcuni leader non resistono alla tentazione di rispondere, per motivi elettorali, alle provocazioni di Trump – magari attraverso la stampa internazionale – è altrettanto vero che la Cina, invece, è un gigante paziente che ragiona con i tempi di un impero millenario e che non si lascia trascinare facilmente dalle minacce contro gli accordi commerciali.
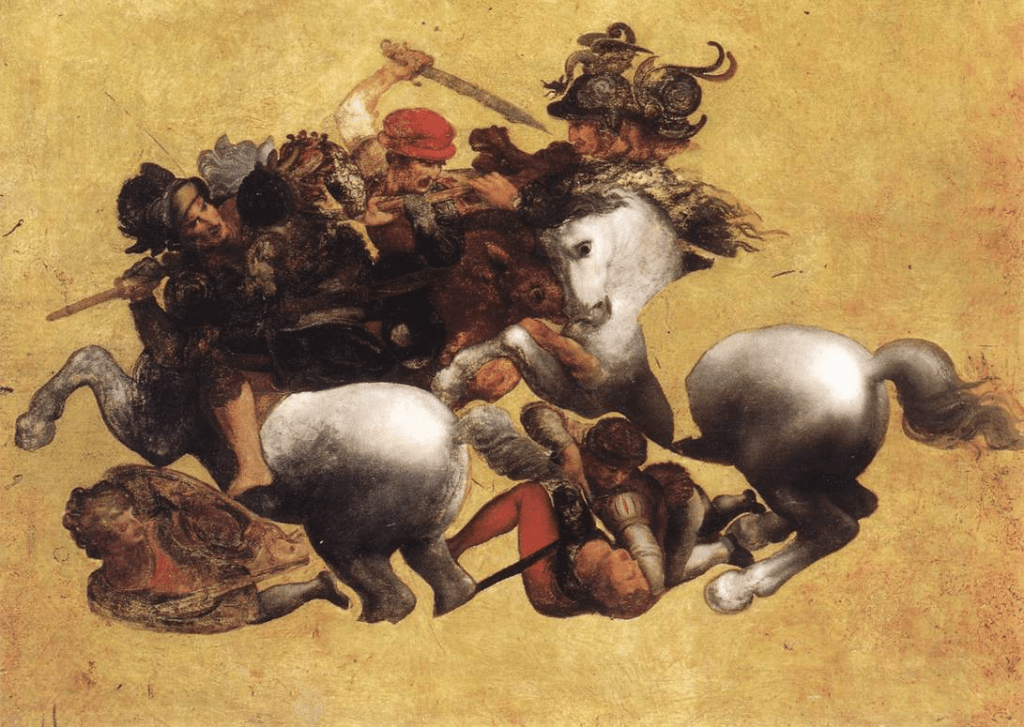


Lascia un commento